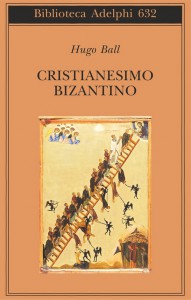Hugo Ball, «Jolifanto bambla»? Macché, è Medio Evo purissimo
Scritto Da Luca Bistolfi il 27 Maggio 2015
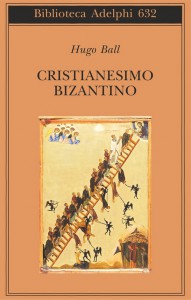
«Jolifanto bambla o falli bambla/großiga m’pfa habla horem/egiga goramen/higo bloiko russula huju/hollaka hollala/anlogo bung/blago bung blago bung/bosso fataka/ü üü ü/schampa wulla wussa olobo/hej tatta gorem/eschige zunbada/wulubu ssubudu uluwu/ssubudu/tumba ba-umf/kusa gauma/ba – umf».
Questi “versi” dada di Hugo Ball campeggiano come epigrafe alla voce di Wikipedia dedicata allo scrittore tedesco. Come a dirne e fissarne per sempre la versione ufficiale, che si declina siffatta ovunque. Ma si potrà dire a ragione che si tratta d’un falso storico. Ball “prestò servizio” nel dadaismo per circa un paio d’anni, anche se nel 1916 ne aveva scritto addirittura il manifesto e fu proprio lui a inventare il nome «dada». (A questo punto s’imporrebbe una rivalità sulla paternità: Ball o Tzara? Ma non importa, andiamo oltre). Due anni edificati più su di un rigetto giovanile del mondo moderno – come lo Julius Evola di quel periodo – che non su di un reale convincimento. Chiusa questa esperienza col secolo, e dopo un’ulteriore breve parentesi nel giornalismo, si ritira in Svizzera, nel Canton Ticino, e qui ritorna ai Padri. Qui nasce l’autentico Hugo Ball. È infatti del 1923 un capolavoro di libro dal titolo icasticamente tradizionale: Cristianesimo bizantino. Lo stampa ora per la prima volta in Italia Adelphi, accompagnandolo con una recensione di Hermann Hesse (sul quale Ball nel 1927 avrebbe scritto una biografia), che mette a fuoco due interessanti punti della vita dell’ex dada, tra loro connessi: una delusione politica dovuta al rigetto e alla censura subiti da un’altra sua opera, Critica all’intellighenzia tedesca (1919), che a sua volta suscita l’irruzione nella vita di Hugo Ball d’un ésprit religioso e contemplativo sino a quel momento sopito, ancorché giammai accantonato. Scrive Hesse:
«Hugo Ball, allora interamente preso dalla politica e immerso nelle vicende del momento e negli orizzonti contingenti, anche se già non estraneo alla contemplazione, ha continuato nel frattempo il suo percorso interiore in fecondi anni di silenzio e fermezza, senza essere toccato dall’insuccesso della sua prima e più ponderosa opera».
Primo frutto di questi anni di studio “sano e traboccante di speranza” è un trittico biografico, le vite di tre santi, «composte similmente agli scrittori del primo cristianesimo» (Hesse), san Giovanni Climaco, san Dionigi Aeropagita e san Simeone Stilita. Pagine agiografiche nel senso tecnico, ma prive di quell’afrore di sagrestia che in certuni casi promana dalle penne infelici di chi, orbo di gioie metafisiche, si limita e limita l’oggetto della propria narrazione a una più o meno lunga teoria di fatti e fatterelli miracolosi, che abbagliano il lettore per qualche istante ma non lo illuminano. C’è tutta la devozione che si deve ai santi Padri, senza sdolcinatezze, ma anzi tutta festosa della virilità propria dell’ascesi più estrema, delle incandescenti arditezze della speculazione teologica e metafisica più cogente e, al contempo, rarefatta. Leggere queste pagine è un’esperienza antimoderna, inadatta a chi partecipa allo spirito del tempo attuale, tanto che potrebbe rivelarsi fatale, come ai Corinti sarebbe stato il cibo solido in luogo del latte. Cristianesimo bizantino è un ammirato e sottomesso sguardo per quei Padri che informano della loro scienza sacra l’Ortodossia, quel Cristianesimo orientale attore, insieme al latino, dello scisma del 1054. Uno sguardo vieppiù sorprendente se pensiamo che proviene da un cattolico. Le scomuniche tra Roma e Bisanzio furono abrogate da Paolo VI e dal Patriarca di Costantinopoli Atenagora, ma invano, solo nel 1964. Per secoli, quando non s’ignoravano, i due polmoni eurasiatici del Cristianesimo, si guardarono in cagnesco, ciò che ancor oggi, nonostante tutti i proclami d’un ecumenismo di facciata e non voluto da nessuna delle due parti, perdura con rara alacre caparbietà. Un rapporto che ha fatto sì che per secoli, se non oltre, i testi fondativi del Cristianesimo, quali appunto quelli dei Padri orientali (che per mille anni sono stati patrimonio della Chiesa indivisa), siano stati ignorati. Ma un rapporto diremmo volentieri necessario: l’Occidente non può abitare quei luoghi. La teologia apofatica di Dionigi Aeropagita, per esempio, l’impianto profondamente metafisico orientale, d’ascendenza necessariamente perennialista, mal s’attagliano all’esclusivismo cattolico e alla tendenza incoercibile dell’Occidente, declinato in tutte le sue forme, anche quella religiosa, di affermare, di aggiungere, di allargarsi, d’invadere tutto e tutti, persino e soprattutto Dio, con la sua idolatrata ragione. Una boria che lievita sempre di più. E dalle pagine di Cristianesimo bizantino – una sintesi ideale per chiunque voglia addentrarsi nello sdrucciolevole ma sontuoso palazzo della teologia negativa e dei conflitti dottrinali tra mondo cosiddetto pagano e Cristianesimo nascente – emerge con sincera e amorevole forza questo gusto orientale, questa taoista cedevolezza, quest’assenza del raglio d’asino che inesausto ripete sempre io-io-io, talché, per citare ancora Hesse, «non se ne può parlare senza un sentimento di grande amore e riconoscenza». In queste pagine «un’aria chiara e tersa spira – è ancora Hesse che parla – intorno alle figure che egli descrive con misura, fedeltà, quasi in maniera impersonale – e aleggia un’atmosfera di purezza, come nelle opere dell’Alto Medioevo». Al di là di qualche sensibile errore, questo libro ha il merito indiscutibile di mettere nelle mani del lettore quattro messaggi, l’uno legato all’altro come in un’aurea catena. Il primo concerne naturalmente il contenuto vero e proprio del testo: vita e dottrina di tre giganti dello spirito orientale cristiano; il secondo è portare a uno spicchio di lettori occidentali il pensiero e la conoscenza, teorica e pratica, d’una teologia non dogmaticamente totalizzante bensì spiritualmente totalizzante; terzo, offrire una visione del cristianesimo non stantìa e non clerical-moraleggiante, ma al contempo neppur buonista ed “ecumenista”; e, infine, dare testimonianza, felice e trasparente, d’un fatto decisivo e cruciale. Questo: non v’è niente che paghi meno dell’iconoclastia, del rigetto della tradizione e della pretesa di distruggere il mondo senza aver concetto e capacità di fondarne uno nuovo. Al quale però si dovrà pur sempre metter mano anzitutto a partire dalla propria interiorità e da coloro i quali, come bussole infallibili e impenetrabili corazze, possono indicarci la strada e porre le nuove fondamenta in attesa d’una nuova primavera dell’umanità, appunto i Padri. La parabola di Hugo Ball è infatti paradigmatica ed edificante: una gioventù spesa tra “rivoluzione” declinata artisticamente va a svaporare (direi quasi: necessariamente) nella rivoluzione autentica, nell’apokatástasis della mente e del cuore, ossia nel ritorno alla tradizione. Ecco la vera rivoluzione: l’epistrofé, il ritorno in vita dell’anima a Dio. Tutto il resto è dada.