Tevere di Luciana Capretti: il dolore di una donna
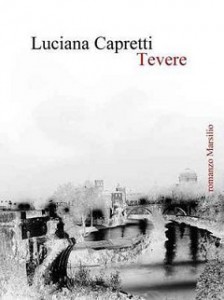 Quando una donna soffre psicologicamente, l’uomo non l’aiuta. I figli non accettano una mamma in difficoltà, si sentono traditi. E anche questo non aiuta le donne. La depressione curata come un patologia psichiatrica, ma è un male dell’anima, non del cervello. Non ha sede in qualche parte del corpo. Non c’è elettroshock che possa sanare il dolore del passato, come quello di Clara, nel romanzo di Luciana Capretti “Tevere”, Marsilio editore, 224 pagine 17,50 euro.
Quando una donna soffre psicologicamente, l’uomo non l’aiuta. I figli non accettano una mamma in difficoltà, si sentono traditi. E anche questo non aiuta le donne. La depressione curata come un patologia psichiatrica, ma è un male dell’anima, non del cervello. Non ha sede in qualche parte del corpo. Non c’è elettroshock che possa sanare il dolore del passato, come quello di Clara, nel romanzo di Luciana Capretti “Tevere”, Marsilio editore, 224 pagine 17,50 euro.
Roma, 1975. Ha indossato un cappotto sulla sottoveste. Scende all’Isola Tiberina. Il fiume è in piena per le piogge, trascina tronchi. L’acqua è nera e maestosa, gelida, rapida, cattiva, sporca. Lei non voleva avere paura, ma nel 1940, a Novara, la paura circolava per strada. Era scoccata “l’ora del destino” e gli anni della guerra rappresentano uno dei tre momenti della vita della protagonista e della narrazione. Tre età, tre periodi, tre colori, ognuno un capitolo: giallo nero bianco, a inseguirsi, giallo nero bianco.
Giallo. Il letto sfatto. “Perdonatemi, 50 anni mi bastano, mi troverete nel Tevere”, ma il corpo non c’è. Una famiglia borghese, chiusa in se stessa, è il ’75, società dei consumi ancora acerba. Quattro persone vivono senza dirsi niente. Virginia e Giovanni, i figli. Clara, arrabbiata, depressa, schiacciata. Giuseppe, il marito, sceneggiatore. Si amavano, si sono amati, ma non la guarda più da tanto. “Non ha idea dove possa essere sua moglie”, gli chiede il commissario?
Nero. Nel novarese, il padre eroe di guerra e fascista, la madre schiava e senza parola, il gatto “Vincere”, la sorellina Mirna, l’altra, Virginia, se n’è andata in un incidente domestico. Clara sta crescendo, guarda i ragazzi, le piace uscire, ballare. Con l’inchiostro, si dipinge la cucitura delle calze velate sulle gambe nude, poi cancella in fretta, tornando a casa. È minorenne: padre padrone, tutto un “NO”. È un mondo antico, non facile, non bello, non sereno. E ci sarà di peggio: l’armistizio, la resistenza, scegliere con chi stare. E le scelte possono essere sbagliate.
Bianco. La ragazza si fa donna. Vive a Roma, sposa felice. Ma quando arriva, il dolore è come un pugno improvviso che la sorprende, la rende incapace di reagire. Dentro, sente un lamento strozzato. Sale su fino a toglierle il respiro, a trasformarsi in grido, a farla crollare sul pavimento.
Giallo bianco nero. Camicia nera. Clara ha sentito il duce, dal Garda, chiamare le donne a fare la loro parte. È la prima volta, pensa, che le donne possono agire. Lei ci sta. Va al Fascio a offrirsi volontaria, ausiliaria della RSI, autonoma, può ricominciare a uscire, incontrare persone. Una scelta più innocente di tante scelte colpevoli. Ma è l’origine di un dramma, arrivati alla resa feroce dei conti.
Un romanzo italiano che ha forza, che prende. Alcune pagine sono bellissime. “Il giorno in cui morì, Virginia era particolarmente lamentosa”… “A Clara, “piacevano i fichi, non ne mangiò più”, scrive Luciana, ispirata… “Era sparita come la sera di gennaio quando l’acqua torbida e nera del Tevere aveva preso la sua anima. Il corpo era morto prima. Una notte lontana di primavera”.


