Mario Capanna: storia d’un impegnato. A non morir d’oblio e di vergogna
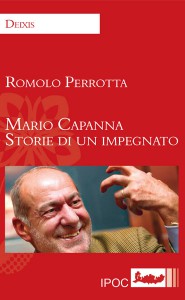 Mario Capanna rappresenta tutto quanto ci è di più distante. Tutto o quasi e il quasi sta nell’esser credente in Dio. Ciò però non toglie che quel Sessantotto di cui il rivoluzionario di professione è coram populo incarnazione perché «interprete più fedele» (ipse dixit a «Reputescion» di Andrea Scanzi) abbia creato a quelli della mia generazione, e non solo, non pochi problemi. Sobbalzo ora nel ritrovarmi tra le mani il libro di Romolo Perrotta (non dappoco: trecento e più pagine, con tanto di fotografie fuori testo), dal titolo Mario Capanna. Storie di un impegnato, edito dal meritorio editore Ipoc (Milano 2015), che, detto per inciso, è da tener d’occhio tra quelle case editrici piccole, sì, ma che lavorano davvero bene da ogni punto di vista. Sobbalzo perché alla sfacciataggine non c’è limite. Ci troviamo infatti di fronte al panegirico di chi incarna, senza minimamente provarne un po’ di vergogna, la peggior epoca con i peggiori risultati, che sia sgorgata dagli avanzi dell’eredità antifascista italoide, con pure pretese di restare un capo morale e politico, un riferimento per le generazione a venire. Chi è stato studente con quella classe di docenti usciti dalle schiere del Sessantotto – che vi abbiano preso parte attiva o abbiano solo profittato delle agevolazioni scolastiche e universitarie poste in essere dalla cosiddetta contestazione poco conta – ha potuto saggiare sulla propria pelle la qualità di certe pretese. Idem per chi, avendo compiuto scelte politiche non conformi, si sia dovuto incontrare-scontrare con il becero fanatismo dei relitti sessantottini, dei loro figli e nipoti. Ogni fenomeno è complesso, certo, lo scrivente è il primo ad affermarlo, ma, evangelicamente, gli alberi si riconoscono dai loro frutti. E chi ha avuto la ventura d’assaggiare questi frutti ma anche la grazia di gustare quelli delle generazioni precedenti con professori formatisi prima di quella fatidica data, avrà senz’altro l’onestà di dire le cose come stanno, di chiamarle col loro nome. Senza contare poi che la libertà di cui s’andava cianciando in quegli anni era più che mai a senso unico: chi non la pensava in una certa maniera, era defenestrato. E non solo in senso metaforico, anzi. Se, come crediamo, non bastasse la nostra personalissima e trascurabilissima posizione in merito al Sessantotto, ci appelliamo all’autorità di due osservatori dell’epoca, che colgono il fenomeno sotto due punti di vista differenti, ancorché complementari: culturale da una parte, umano e politico dall’altra. Iniziamo con Roberto Alonge. Quest’ultimo è al grande pubblico senz’altro poco noto, per non dire pressoché sconosciuto. Insino a poco tempo fa, insegnava presso l’Università di Torino. Uomo di sinistra, comunista, quindi non certo un “fascista borghese”, egli è autore d’un magnifico libro, dall’eloquente titolo, Asini calzati e vestiti (Utet, 2005), e dall’ancor più eloquente sottotitolo: Lo sfascio della scuola e dell’università dal ’68 a oggi. Chi scrive ebbe voglia di intervistarlo di persona sulla faccenda e ne sentì, nonché ne registrò, delle belle. Il solo libro ovviamente basta e avanza, tant’è ricco di scandalosi episodi registrati da chi visse appieno quel tempo e pure ne fece parte. Episodi mai smentiti. Nonostante l’ignoranza montante e conseguente, però, qualcuno si è salvato, non tutti sono diventati, o rimasti, degli asini. Anzi, se c’è un buon prodotto del Sessantotto sono stati gli anticorpi che qualche graziato ha sviluppato per naturale predisposizione e/o per reazione agli ultimi colpi che l’Italia dell’arte, della letteratura, delle filosofia e del diritto stava subendo. Ancorché abbia dovuto subire i danni collaterali d’una certa pedagogica e d’una certa didattica. L’altro osservatore che chiamiamo in causa è anch’egli di sinistra (almeno come formazione), ovvero Massimo Fini. Ci si rilegga il mazzetto di articoli dedicati a «Sessantotto, terrorismo, pentiti», oggi ristampati nel Conformista. Contro l’anticonformismo di massa (Marsilio 2008). Spigoliamo una manciatina di frasette dall’articolo «Ma che bravi questi eroi del Sessantotto»: «Oggi che le strade d’Italia sono bagnate si sangue al ritmo di tre morti al giorno c’è un corri corri degli “ex sessantottini”… a prendere le distanze dalla violenza». Vero? «Niente affatto. Non sarebbero “sessantottini” se si comportassero in questo modo. Si guardano bene dal muovere a se stessi anche l’ombra di un rimprovero: condannano le violenze di oggi ma continuano a ritenere giuste le violenze di ieri, le loro violenze. Dichiara Giaime Pintor…: “Nel Sessantotto la violenza era una tattica. Nell’Autonomia di oggi è diventata una strategia. Questo è l’abisso che ci separa”. In quanto a Martucci [allora segretario del Mls, ex Movimento studentesco, ndr] distingue fra “la passata violenza di autodifesa e quella autonoma intesa come ipotesi politica”». Al che il giornalista e intellettuale si chiede: «Quando i katanga del Ms [ancora il Movimento studentesco, quello capeggiato proprio da Capanna, ndr] sprangarono quasi a morte il sindacalista della Uil Giuseppe Conti cos’era, tattica?… E quando Sergio Ramelli, missino di diciotto anni fu aggredito, sempre a colpi di spranga [erano chiavi inglese invero, ndr]… e morì dopo quaranta giorni di agonia cos’era, autodifesa? I distinguo sulla violenza fanno pena, ma se proprio volete farli vi dico io… che le violenze del Sessantotto sono ancor meno giustificate di quelle del ’77 e dell’Autonomia. Perché a fare violenza nel Sessantotto erano, nella stragrande maggioranza dei casi, i figli della grande e grandissima borghesia» e poi spiega altri dettagli del glorioso periodo. Chiedendosi infine: «Faccio male a ricordare queste cose, faccio male a ricordare i Ramelli assassinati per nulla?». E diceva già allora Fini, che, sì, faceva male, ché in Italia nessuno ama assumersi la propria responsabilità per fatti e idee propalati con la medesima generosità con cui si irrogavano sprangate in mezzo agli occhi. Insomma, siamo davanti a un fenomeno che di glorioso, a conti fatti anche dai suoi stessi partecipanti, possiede poco o niente. Niente di tutto questo transita per il libro. Perrotta tratteggia non già una biografia di Capanna, bensì compone un’agiografia. Capanna santificato in vita. Una santificazione cui giungono a dar forza, come in ogni processo di canonizzazione, testimonianze di viventi che hanno avuto agio e privilegio di toccar con mano i “miracoli eufemistici” del santo cattocomunista. Ed ecco allora sfilare (tra gli altri e presentati a garanzia sin dal frontespizio, come un piccolo esercito) Giovanni Minoli, padre Zanotelli, Salvatore Natoli, Gaetano Pecorella (forzitaliota ma già in Potere Operaio e poi in Democrazia Proletaria), Franco Piperno, Emanuele Severino, Stefano Rodotà e persino due soggetti politicamente assai distanti da Capanna, quali Gianni Letta e Marcello Veneziani. Il santo è talmente santo che persino due diavoli, uno berlusconiano e l’altro fascista, concorrono alla causa di canonizzazione. Ma di santo, nemmeno in senso illecito e profano, qui non c’è proprio niente. E da ultimo vorrei riferire proprio a tal proposito un episodio di cui sono stato diretto protagonista, avvenuto il 25 gennaio 2014 presso il Centro Culturale Italiano di Cluj-Napoca in Romania, Paese che conosco parecchio bene. Durante la presentazione della Fine dei Ceausescu (Aliberti 2012, mia traduzione del saggio di Grigore Cartianu Sfarsitul Ceausestilor), rivolto a una platea di romeni italianisti e di italiani, ebbi a dire: «I romeni sono fortunati, perché, pur tra tante disgrazie, non hanno avuto il Sessantotto». Fui verbalmente aggredito dagli italiani presenti. In altri anni non so se l’aggressione di sarebbe limitata a esser verbale, ne dubito. Avevo violato un tabù, svélto un totem, l’attaccamento verso il quale abbisognerebbe d’esser fatto valutare da un Freud di passaggio. E questo episodio, insieme a tutti gli altri, mi spinge, in fondo, a dar ragione a Mario Capanna. Furono davvero «formidabili quegli anni», come suona il titolo d’un celebre suo libro (per inciso pubblicato con la “proletaria” Rizzoli). Al nostro “impegnato”, che sa di latino, non sarà infatti certo sfuggito che il termine formidabilis deriva da formido, che non vuole dire ciò che i più intendono, bensì letteralmente paura: quella che diffusero i sessantottini. Ma anche un altro genere di paura: quella di questi stessi individui, vecchi relitti d’una catastrofe annunciata, che oggi tremano alla sola idea di esser, prima, ricordati solo per le loro nefaste responsabilità e, subito dopo, dimenticati e sepolti insieme ai loro morti. Mai definizione per il Sessantotto fu più pertinente. D’altra parte proviene dal suo «interprete più fedele».
Mario Capanna rappresenta tutto quanto ci è di più distante. Tutto o quasi e il quasi sta nell’esser credente in Dio. Ciò però non toglie che quel Sessantotto di cui il rivoluzionario di professione è coram populo incarnazione perché «interprete più fedele» (ipse dixit a «Reputescion» di Andrea Scanzi) abbia creato a quelli della mia generazione, e non solo, non pochi problemi. Sobbalzo ora nel ritrovarmi tra le mani il libro di Romolo Perrotta (non dappoco: trecento e più pagine, con tanto di fotografie fuori testo), dal titolo Mario Capanna. Storie di un impegnato, edito dal meritorio editore Ipoc (Milano 2015), che, detto per inciso, è da tener d’occhio tra quelle case editrici piccole, sì, ma che lavorano davvero bene da ogni punto di vista. Sobbalzo perché alla sfacciataggine non c’è limite. Ci troviamo infatti di fronte al panegirico di chi incarna, senza minimamente provarne un po’ di vergogna, la peggior epoca con i peggiori risultati, che sia sgorgata dagli avanzi dell’eredità antifascista italoide, con pure pretese di restare un capo morale e politico, un riferimento per le generazione a venire. Chi è stato studente con quella classe di docenti usciti dalle schiere del Sessantotto – che vi abbiano preso parte attiva o abbiano solo profittato delle agevolazioni scolastiche e universitarie poste in essere dalla cosiddetta contestazione poco conta – ha potuto saggiare sulla propria pelle la qualità di certe pretese. Idem per chi, avendo compiuto scelte politiche non conformi, si sia dovuto incontrare-scontrare con il becero fanatismo dei relitti sessantottini, dei loro figli e nipoti. Ogni fenomeno è complesso, certo, lo scrivente è il primo ad affermarlo, ma, evangelicamente, gli alberi si riconoscono dai loro frutti. E chi ha avuto la ventura d’assaggiare questi frutti ma anche la grazia di gustare quelli delle generazioni precedenti con professori formatisi prima di quella fatidica data, avrà senz’altro l’onestà di dire le cose come stanno, di chiamarle col loro nome. Senza contare poi che la libertà di cui s’andava cianciando in quegli anni era più che mai a senso unico: chi non la pensava in una certa maniera, era defenestrato. E non solo in senso metaforico, anzi. Se, come crediamo, non bastasse la nostra personalissima e trascurabilissima posizione in merito al Sessantotto, ci appelliamo all’autorità di due osservatori dell’epoca, che colgono il fenomeno sotto due punti di vista differenti, ancorché complementari: culturale da una parte, umano e politico dall’altra. Iniziamo con Roberto Alonge. Quest’ultimo è al grande pubblico senz’altro poco noto, per non dire pressoché sconosciuto. Insino a poco tempo fa, insegnava presso l’Università di Torino. Uomo di sinistra, comunista, quindi non certo un “fascista borghese”, egli è autore d’un magnifico libro, dall’eloquente titolo, Asini calzati e vestiti (Utet, 2005), e dall’ancor più eloquente sottotitolo: Lo sfascio della scuola e dell’università dal ’68 a oggi. Chi scrive ebbe voglia di intervistarlo di persona sulla faccenda e ne sentì, nonché ne registrò, delle belle. Il solo libro ovviamente basta e avanza, tant’è ricco di scandalosi episodi registrati da chi visse appieno quel tempo e pure ne fece parte. Episodi mai smentiti. Nonostante l’ignoranza montante e conseguente, però, qualcuno si è salvato, non tutti sono diventati, o rimasti, degli asini. Anzi, se c’è un buon prodotto del Sessantotto sono stati gli anticorpi che qualche graziato ha sviluppato per naturale predisposizione e/o per reazione agli ultimi colpi che l’Italia dell’arte, della letteratura, delle filosofia e del diritto stava subendo. Ancorché abbia dovuto subire i danni collaterali d’una certa pedagogica e d’una certa didattica. L’altro osservatore che chiamiamo in causa è anch’egli di sinistra (almeno come formazione), ovvero Massimo Fini. Ci si rilegga il mazzetto di articoli dedicati a «Sessantotto, terrorismo, pentiti», oggi ristampati nel Conformista. Contro l’anticonformismo di massa (Marsilio 2008). Spigoliamo una manciatina di frasette dall’articolo «Ma che bravi questi eroi del Sessantotto»: «Oggi che le strade d’Italia sono bagnate si sangue al ritmo di tre morti al giorno c’è un corri corri degli “ex sessantottini”… a prendere le distanze dalla violenza». Vero? «Niente affatto. Non sarebbero “sessantottini” se si comportassero in questo modo. Si guardano bene dal muovere a se stessi anche l’ombra di un rimprovero: condannano le violenze di oggi ma continuano a ritenere giuste le violenze di ieri, le loro violenze. Dichiara Giaime Pintor…: “Nel Sessantotto la violenza era una tattica. Nell’Autonomia di oggi è diventata una strategia. Questo è l’abisso che ci separa”. In quanto a Martucci [allora segretario del Mls, ex Movimento studentesco, ndr] distingue fra “la passata violenza di autodifesa e quella autonoma intesa come ipotesi politica”». Al che il giornalista e intellettuale si chiede: «Quando i katanga del Ms [ancora il Movimento studentesco, quello capeggiato proprio da Capanna, ndr] sprangarono quasi a morte il sindacalista della Uil Giuseppe Conti cos’era, tattica?… E quando Sergio Ramelli, missino di diciotto anni fu aggredito, sempre a colpi di spranga [erano chiavi inglese invero, ndr]… e morì dopo quaranta giorni di agonia cos’era, autodifesa? I distinguo sulla violenza fanno pena, ma se proprio volete farli vi dico io… che le violenze del Sessantotto sono ancor meno giustificate di quelle del ’77 e dell’Autonomia. Perché a fare violenza nel Sessantotto erano, nella stragrande maggioranza dei casi, i figli della grande e grandissima borghesia» e poi spiega altri dettagli del glorioso periodo. Chiedendosi infine: «Faccio male a ricordare queste cose, faccio male a ricordare i Ramelli assassinati per nulla?». E diceva già allora Fini, che, sì, faceva male, ché in Italia nessuno ama assumersi la propria responsabilità per fatti e idee propalati con la medesima generosità con cui si irrogavano sprangate in mezzo agli occhi. Insomma, siamo davanti a un fenomeno che di glorioso, a conti fatti anche dai suoi stessi partecipanti, possiede poco o niente. Niente di tutto questo transita per il libro. Perrotta tratteggia non già una biografia di Capanna, bensì compone un’agiografia. Capanna santificato in vita. Una santificazione cui giungono a dar forza, come in ogni processo di canonizzazione, testimonianze di viventi che hanno avuto agio e privilegio di toccar con mano i “miracoli eufemistici” del santo cattocomunista. Ed ecco allora sfilare (tra gli altri e presentati a garanzia sin dal frontespizio, come un piccolo esercito) Giovanni Minoli, padre Zanotelli, Salvatore Natoli, Gaetano Pecorella (forzitaliota ma già in Potere Operaio e poi in Democrazia Proletaria), Franco Piperno, Emanuele Severino, Stefano Rodotà e persino due soggetti politicamente assai distanti da Capanna, quali Gianni Letta e Marcello Veneziani. Il santo è talmente santo che persino due diavoli, uno berlusconiano e l’altro fascista, concorrono alla causa di canonizzazione. Ma di santo, nemmeno in senso illecito e profano, qui non c’è proprio niente. E da ultimo vorrei riferire proprio a tal proposito un episodio di cui sono stato diretto protagonista, avvenuto il 25 gennaio 2014 presso il Centro Culturale Italiano di Cluj-Napoca in Romania, Paese che conosco parecchio bene. Durante la presentazione della Fine dei Ceausescu (Aliberti 2012, mia traduzione del saggio di Grigore Cartianu Sfarsitul Ceausestilor), rivolto a una platea di romeni italianisti e di italiani, ebbi a dire: «I romeni sono fortunati, perché, pur tra tante disgrazie, non hanno avuto il Sessantotto». Fui verbalmente aggredito dagli italiani presenti. In altri anni non so se l’aggressione di sarebbe limitata a esser verbale, ne dubito. Avevo violato un tabù, svélto un totem, l’attaccamento verso il quale abbisognerebbe d’esser fatto valutare da un Freud di passaggio. E questo episodio, insieme a tutti gli altri, mi spinge, in fondo, a dar ragione a Mario Capanna. Furono davvero «formidabili quegli anni», come suona il titolo d’un celebre suo libro (per inciso pubblicato con la “proletaria” Rizzoli). Al nostro “impegnato”, che sa di latino, non sarà infatti certo sfuggito che il termine formidabilis deriva da formido, che non vuole dire ciò che i più intendono, bensì letteralmente paura: quella che diffusero i sessantottini. Ma anche un altro genere di paura: quella di questi stessi individui, vecchi relitti d’una catastrofe annunciata, che oggi tremano alla sola idea di esser, prima, ricordati solo per le loro nefaste responsabilità e, subito dopo, dimenticati e sepolti insieme ai loro morti. Mai definizione per il Sessantotto fu più pertinente. D’altra parte proviene dal suo «interprete più fedele».



Aprile 10, 2015
Ho
sofferto negli anni ’70 – primi ’80 tutte le ubbie di persone come il Capanna, le discriminazion i e le violenze di altri, fanatici con e senza libretto rosso, sul posto di lavoro, in ogni àmbito sociale. Non si deprecherà mai abbastanza l’impazzimento di quegli anni di cervelli all’ammasso, come scriveva Montanelli.
Cordialmente.
Guido Pagliarino