Cacciari al fondo del suo “Labirinto filosofico”
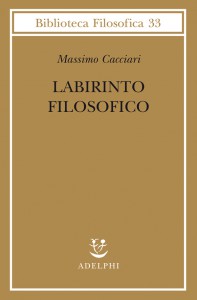 A ogni nuovo saggio Massimo Cacciari conferma se stesso, nel bene e nel “male”. Col suo ultimo Labirinto filosofico (Adelphi, 2014, pp. 248, 38 euro) egli mette a nudo ancora una volta la sua grandezza di pensatore (filosofico) e l’impotenza (absit iniuria verbo) della filosofia contemporanea a essere, finalmente e davvero, sophía. Ed è proprio questo il centro di gravità, più che gli altri temi in esso contenuti, di quest’ultima prova, di quest’ultimo tentativo – magistrale, s’intende – di dire il contenuto stesso della filosofia e, di poi, il fine ultimo dell’uomo. Cacciari è senz’altro l’ultimo grande pensatore strettamente filosofico-occidentale che vi sia in circolazione. Non ci riferiamo ad altri, ché per costoro il problema centrale della filosofia – o meglio: il suo centro tout-court – è svélto ab imis, come per esempio in Emanuele Severino o, peggio, nel pensiero debole di Gianni Vattimo («Della verità non m’importa un fico secco», ebbe a dichiarare). Il pensatore veneziano pone sempre il problema, quel problema, quel centro nei suoi testi: il passaggio che va dal “semplice” amare la sophía a quello che fa dell’amante un autentico sophós. Un capitolo tra gli altri segnaliamo, ovvero «La terribile paroletta»: non a caso, dacché pone un problema decisivo per la filosofia, ossia quello legato al linguaggio; e la sezione in cui troviamo questo unico capitolo è intitolata per l’appunto proprio «Pensiero e linguaggio». Questa «terribile paroletta» è essere. «Ancora?!», si esclamerà. Ancora, sì. Ancora sinché il pensiero occidentale non avrà trovato la chiave di volta per decidersi, una volta per tutte, sul significato di tale termine, senza accapigliarsi come in un qualsiasi condominio. Sinché la filosofia occidentale si ostinerà a restar ferma alla risultante della sua degenerazione epocale, che ha spezzato il legame con la Grecia, la quale alla sua volta traeva dall’India (come ben vide Simone Weil) e in particolare dal Veda, non si potrà far altro che perdersi in un labirinto, la cui uscita sembra condurre in un altro labirinto, e così via. Ed ecco qui il vulnus, l’«impotentia philosophandi» cui faceva cenno, per esempio, un altro filosofo, Manlio Sgalambro, in quel libello dall’ingannevole titolo La consolazione (Adelphi, 1995). Per Sgalambro ogni filosofia è cessata e da qui sorge la figura dello scrittore di filosofia, «che può tutto quanto quello non può». Quindi la scelta parrebbe tra scontare questa impotenza e dismettere i panni del filosofo (per quanto già questa figura abbia in Occidente da secoli perduto la sua radice greco-orientale) oppure diventare finalmente sophós uscendo da questi labirinti, «a riveder le stelle». La domanda che ogni lettore dovrà infatti porsi prima di addentrarsi nel labirinto di Massimo Cacciari sarà appunto: esiste invero un’uscita? Abbiamo qualche ragione per dubitarne: quello del nostro filosofo non è il labirinto di Teseo.
A ogni nuovo saggio Massimo Cacciari conferma se stesso, nel bene e nel “male”. Col suo ultimo Labirinto filosofico (Adelphi, 2014, pp. 248, 38 euro) egli mette a nudo ancora una volta la sua grandezza di pensatore (filosofico) e l’impotenza (absit iniuria verbo) della filosofia contemporanea a essere, finalmente e davvero, sophía. Ed è proprio questo il centro di gravità, più che gli altri temi in esso contenuti, di quest’ultima prova, di quest’ultimo tentativo – magistrale, s’intende – di dire il contenuto stesso della filosofia e, di poi, il fine ultimo dell’uomo. Cacciari è senz’altro l’ultimo grande pensatore strettamente filosofico-occidentale che vi sia in circolazione. Non ci riferiamo ad altri, ché per costoro il problema centrale della filosofia – o meglio: il suo centro tout-court – è svélto ab imis, come per esempio in Emanuele Severino o, peggio, nel pensiero debole di Gianni Vattimo («Della verità non m’importa un fico secco», ebbe a dichiarare). Il pensatore veneziano pone sempre il problema, quel problema, quel centro nei suoi testi: il passaggio che va dal “semplice” amare la sophía a quello che fa dell’amante un autentico sophós. Un capitolo tra gli altri segnaliamo, ovvero «La terribile paroletta»: non a caso, dacché pone un problema decisivo per la filosofia, ossia quello legato al linguaggio; e la sezione in cui troviamo questo unico capitolo è intitolata per l’appunto proprio «Pensiero e linguaggio». Questa «terribile paroletta» è essere. «Ancora?!», si esclamerà. Ancora, sì. Ancora sinché il pensiero occidentale non avrà trovato la chiave di volta per decidersi, una volta per tutte, sul significato di tale termine, senza accapigliarsi come in un qualsiasi condominio. Sinché la filosofia occidentale si ostinerà a restar ferma alla risultante della sua degenerazione epocale, che ha spezzato il legame con la Grecia, la quale alla sua volta traeva dall’India (come ben vide Simone Weil) e in particolare dal Veda, non si potrà far altro che perdersi in un labirinto, la cui uscita sembra condurre in un altro labirinto, e così via. Ed ecco qui il vulnus, l’«impotentia philosophandi» cui faceva cenno, per esempio, un altro filosofo, Manlio Sgalambro, in quel libello dall’ingannevole titolo La consolazione (Adelphi, 1995). Per Sgalambro ogni filosofia è cessata e da qui sorge la figura dello scrittore di filosofia, «che può tutto quanto quello non può». Quindi la scelta parrebbe tra scontare questa impotenza e dismettere i panni del filosofo (per quanto già questa figura abbia in Occidente da secoli perduto la sua radice greco-orientale) oppure diventare finalmente sophós uscendo da questi labirinti, «a riveder le stelle». La domanda che ogni lettore dovrà infatti porsi prima di addentrarsi nel labirinto di Massimo Cacciari sarà appunto: esiste invero un’uscita? Abbiamo qualche ragione per dubitarne: quello del nostro filosofo non è il labirinto di Teseo.


